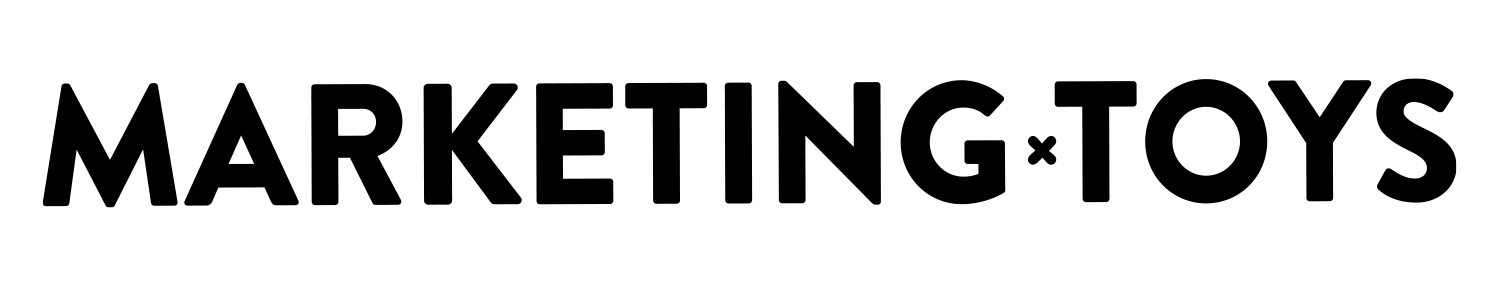Riflessioni speculative a partire da un robot chiamato gita®
Qualche giorno fa, quasi per caso, ci siamo imbattuti in un progetto che ci ha costretto a rallentare. Non perché fosse particolarmente complesso o difficile da capire, ma per il motivo opposto: era tutto fin troppo chiaro. Talmente chiaro da risultare stranamente familiare.
Stiamo parlando di Piaggio Fast Forward, il progetto lanciato qualche anno fa dal Gruppo Piaggio con sede a Boston. Una sorta di spin-off visionario che lavora su sistemi di mobilità leggera, autonoma, pensati per convivere con il corpo umano. Il loro prodotto più emblematico si chiama gita®: un robot su due ruote, grande quanto una valigia, capace di seguirti ovunque portando oggetti per te. Come un compagno silenzioso. Come un'estensione funzionale (e quasi emotiva) della tua persona.
Ed è proprio lì che ci si ferma. Perché c'è qualcosa in gita che va oltre il design industriale, oltre l’innovazione tecnica o la tecnologia applicata. C'è un’eco. Un riverbero di idee già pensate, già raccontate, già viste… ma altrove. In altri tempi, in altri linguaggi. Nella fantascienza. Nell’arte. Nelle visioni speculative che popolano le narrazioni di futuri possibili.
Questo è speculative design. Dal vivo.
Uno degli assunti chiave del design speculativo è che non serve a prevedere il futuro, ma a metterlo in discussione. È un atto critico, narrativo, immaginativo. Serve a incarnare ipotesi, provocare riflessioni, costruire mondi e interrogativi sotto forma di oggetti, interfacce, rituali. Serve a progettare non per il “mercato” ma per la possibilità.
Spesso resta nei laboratori, nelle aule universitarie, nei festival di arte e tecnologia. Ma ogni tanto succede qualcosa di raro: uno di questi artefatti “esce di casa”. Cammina nel mondo. E lo fa senza smettere di essere una domanda aperta.
Ecco, gita sembra proprio questo: una domanda con le ruote.
Un oggetto progettato non tanto per soddisfare un bisogno, ma per esplorare uno scenario. In questo caso: cosa succede se immaginiamo la mobilità urbana non come qualcosa da velocizzare, ma da rendere più umana? Cosa cambia se invece di costruire esoscheletri ipertecnologici per aumentare la nostra performance, creiamo piccoli assistenti che si adattano ai nostri ritmi? E ancora: cosa significa camminare accompagnati da un oggetto non umano, ma che si comporta come un alleato?
La posta in gioco non è tecnologica. È culturale.
Il valore di questi progetti non si misura solo in termini di funzionalità o vendite, ma in ciò che riescono a evocare. In come riescono a spostare lo sguardo. A farci vedere diversamente ciò che consideriamo “normale”, o persino “inevitabile”. A suggerire che le alternative esistono. E che il futuro, in fondo, può ancora sorprenderci.
Per chi come noi lavora con e attraverso il design — non come soluzione immediata ma come strumento trasformativo — vedere un oggetto come gita uscire dallo spazio concettuale ed entrare nella vita quotidiana è una piccola gioia. È la conferma che esiste uno spazio di intersezione tra immaginazione e produzione, tra utopia e industria, tra futuro e presente.
Ed è proprio in questo spazio che ci piace giocare.
Perché no, non tutti i progetti devono “risolvere un problema”.
Alcuni devono semplicemente farci domande migliori.
E magari, farcele mentre ci seguono a passo lento, in un marciapiede qualunque.
Qualche giorno fa, quasi per caso, ci siamo imbattuti in un progetto che ci ha costretto a rallentare. Non perché fosse particolarmente complesso o difficile da capire, ma per il motivo opposto: era tutto fin troppo chiaro. Talmente chiaro da risultare stranamente familiare.
Stiamo parlando di Piaggio Fast Forward, il progetto lanciato qualche anno fa dal Gruppo Piaggio con sede a Boston. Una sorta di spin-off visionario che lavora su sistemi di mobilità leggera, autonoma, pensati per convivere con il corpo umano. Il loro prodotto più emblematico si chiama gita®: un robot su due ruote, grande quanto una valigia, capace di seguirti ovunque portando oggetti per te. Come un compagno silenzioso. Come un'estensione funzionale (e quasi emotiva) della tua persona.
Ed è proprio lì che ci si ferma. Perché c'è qualcosa in gita che va oltre il design industriale, oltre l’innovazione tecnica o la tecnologia applicata. C'è un’eco. Un riverbero di idee già pensate, già raccontate, già viste… ma altrove. In altri tempi, in altri linguaggi. Nella fantascienza. Nell’arte. Nelle visioni speculative che popolano le narrazioni di futuri possibili.
Questo è speculative design. Dal vivo.
Uno degli assunti chiave del design speculativo è che non serve a prevedere il futuro, ma a metterlo in discussione. È un atto critico, narrativo, immaginativo. Serve a incarnare ipotesi, provocare riflessioni, costruire mondi e interrogativi sotto forma di oggetti, interfacce, rituali. Serve a progettare non per il “mercato” ma per la possibilità.
Spesso resta nei laboratori, nelle aule universitarie, nei festival di arte e tecnologia. Ma ogni tanto succede qualcosa di raro: uno di questi artefatti “esce di casa”. Cammina nel mondo. E lo fa senza smettere di essere una domanda aperta.
Ecco, gita sembra proprio questo: una domanda con le ruote.
Un oggetto progettato non tanto per soddisfare un bisogno, ma per esplorare uno scenario. In questo caso: cosa succede se immaginiamo la mobilità urbana non come qualcosa da velocizzare, ma da rendere più umana? Cosa cambia se invece di costruire esoscheletri ipertecnologici per aumentare la nostra performance, creiamo piccoli assistenti che si adattano ai nostri ritmi? E ancora: cosa significa camminare accompagnati da un oggetto non umano, ma che si comporta come un alleato?
La posta in gioco non è tecnologica. È culturale.
Il valore di questi progetti non si misura solo in termini di funzionalità o vendite, ma in ciò che riescono a evocare. In come riescono a spostare lo sguardo. A farci vedere diversamente ciò che consideriamo “normale”, o persino “inevitabile”. A suggerire che le alternative esistono. E che il futuro, in fondo, può ancora sorprenderci.
Per chi come noi lavora con e attraverso il design — non come soluzione immediata ma come strumento trasformativo — vedere un oggetto come gita uscire dallo spazio concettuale ed entrare nella vita quotidiana è una piccola gioia. È la conferma che esiste uno spazio di intersezione tra immaginazione e produzione, tra utopia e industria, tra futuro e presente.
Ed è proprio in questo spazio che ci piace giocare.
Perché no, non tutti i progetti devono “risolvere un problema”.
Alcuni devono semplicemente farci domande migliori.
E magari, farcele mentre ci seguono a passo lento, in un marciapiede qualunque.